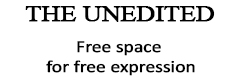Cresce il consenso in Europa ed in Italia per l’adozione del (mini)nucleare di nuova generazione a sicurezza intrinseca, ma va consolidato ed ampliato via programma quadro di lungo termine dell’Ue, un New Euratom, e progetti nazionali autonomi. Ma questi euroconnessi e correlati ad una politica ambientale che metta in priorità l’ecoadattamento nei confronti della decarbonizzazione sapendo che l’accelerazione del nucleare poi avrà effetti decarbonizzanti. In sintesi: energia abbondante meno costosa e più pulita grazie alla crescente diffusione del mini-nucleare supersicuro. Vediamo alcuni punti chiave dello scenario a 25 anni.
Priorità dell’ecoadattamento. Dal punto di vista dell’economia il dato certo (NASA) è l’aumento delle temperature e quello correlato dei fenomeni meteo estremi (evidenze corroborate dall’incremento del costo dei danni sia per le assicurazioni sia per i bilanci statali). Dall’analisi geopolitica si ricava che le nazioni non stanno attivando politiche decarbonizzanti significative: pertanto la politica decarbonizzante, giusta o sbagliata che sia, non è una soluzione ai problemi del cambiamento climatico per il semplice fatto che non esiste. Quindi la priorità è l’ecoadattamento e non la decarbonizzazione.
Il nucleare come soluzione al problema di come ottenere più energia pulita a costi minori. Il mio gruppo di ricerca (Stratematica) non vede un conflitto tra ecoadattmento e decarbonizzazione se venisse accelerata la diffusione di minicentrali nucleari a fissione e poi di centrali necessariamente più grandi a fusione. Stiamo raffinando una simulazione dove la diffusione del nuovo nucleare porta in circa 25 anni ad una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall’impiego dei combustibili fossili. Stiamo aspettando dalla fisica lo schema per calcolare se tale crescita del nucleare pulito possa avere un effetto sul cambiamento climatico. Tuttavia, anche se l’Europa accelerasse la riduzione di gas serra, resta il dato (al momento) che le altre parti del mondo non lo farebbero o sarebbero più lente. Problema? A livello globale resta aperto, ma per quello europeo bisogna considerare che Ue ed Italia sono importatori di energia con impatto negativo sulla competitività. Pertanto resta la priorità dell’eco-adattamento rapido via nucleare residente come fonte primaria. Ma un altro obiettivo è più ecorilevante.
Ecologia artificiale sostenuta da un aumento dell’energia nucleare a basso costo. Non ci sono segnali realistici di un contenimento del cambiamento climatico. Pertanto è prudente scenarizzare, per prevenzione, la continuità dell’aumento delle temperature e relativi effetti. Per inciso, siamo in attesa di una ricerca a cui partecipa il Cnr italiano che dai carotaggi più che millenari del ghiaccio antartico cerca di valutare il cambiamento climatico avvenuto in era non industriale, dato utile per proiezioni nel nostro secolo. Ma abbiamo inserito nella ricerca tanti dati archeologici: impressionanti quelli del Sahara dove in circa 4.000 anni si è passati da un ambiente tipo savana ad un deserto. Tale dato ci ha spinto ad una simulazione proiettiva dell’ambiente italiano che ha individuato un rischio di desertificazione e ci ha convinto a sostenere con più forza la strategia ecoadattiva di “ecologia artificiale”, gradualizzata ed evolutiva entro la fine del secolo: a) aumento calibrato con zonazione del rischio di dissalatori per mantenere abbondante la fornitura di acqua dolce civile e per irrigazione; b) sperimentazione iniziale di produzioni agricole in serra climatizzata per essere pronti a questa agroindustrializzazione, eventualmente, nel prossimo futuro (siamo ansiosi di vedere come funzioneranno le tecniche di Bonifiche ferraresi nella missione di verdeggiare la desertica Algeria); c) sperimentazione sia di mega-lavori di terraformazione per essere pronti ad impiegarla dove l’aumento del livello del mare lo richiederà per contenimento sia terraformazione localizzata per ridurre il rischio idrogeologico; d) estensione graduale e sperimentale degli ambienti climatizzati in aree urbane e facilitazione per gli impianti domestici. La lista è più lunga, ma questo cenno è sufficiente per far intuire quanta più energia serva per l’ecoadattamento oltre che per la nuova cibernetica della comunicazione, per la mobilità elettrica, ecc. Il nucleare a fissione di nuova generazione e più avanti quello a fusione sono la giusta risposta al nuovo fabbisogno.
Armonizzazione tra politica ambientale ed energetica. Le norme europee basate sull’illusione di una decarbonizzazione veloce hanno creato un conflitto tra economia e politica ambientale a danno della prima e senza alcun vantaggio rilevante per la seconda. Mettere in priorità l’ecoadattamento sostenuto dall’aumento della produzione di energia nucleare è un modo per ricostruire un’armonizzazione tra requisiti di sostenibilità ed industria.
La nuova matrice pragmatica per le fonti di energia. La sostituzione dei combustibili fossili ad alti costi di importazione implica una fonte con capacità produttiva enorme e non intermittente. Ma non esclude le fonti intermittenti dove mostrino costanza ed efficienza sufficienti: solare ed eolico. Tantomeno esclude (in Italia) il ricorso all’energia idroelettrica fino che le precipitazioni saranno sufficienti. Quindi si tratta di costruire una rete (pan-europea) con fonti differenziabili, ma centrata sul nuovo nucleare.
Come anticipare il nucleare. Aumentando l’investimento europeo e trovando formule pubblico-privato con il criterio “più capitale più velocità”. Obiettivo possibile? Primi test nel 2028-29 invece che nel 2030-32 come oggi previsto. Poi velocizzare la scelta ed autorizzazione per localizzare i nuovi impianti così incentivandone la produzione in serie.