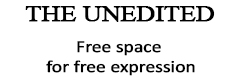L’annuncio del 30% di dazi statunitensi all’export europeo per aprire di più via pressione l’Ue e sue barriere non tariffarie a quello di Washington è una mossa pesante. Ma, pur possibile per reazione la minore disponibilità degli europei all’acquisto di armi statunitensi, non penso ci sarà una rottura degli accordi Nato che incrementano la spesa per la sicurezza. Pertanto resta oggetto prioritario di attenzione il come, iniziando da un chiarimento: quale spesa di sicurezza si trasforma in crescita ed innovazione tecnologica/economica, cioè in investimento produttivo, e quale no. Ho iniziato un programma di ricerca in materia, qui alcuni risultati preliminari.
Sopra questa ricerca c’è quella sull’evoluzione della guerra. Oggi è evidente un salto qualitativo/tecnologico discontinuo, quasi da fantascienza, degli strumenti bellici. Poi va considerato che la sicurezza oggi non è solo militare o solo di presidio del territorio con mezzi di polizia e implica un’evoluzione delle capacità cognitive ed organizzative della popolazione civile in casi d’emergenza e/o di allarme. Per esempio, gli stati nordici europei, perché prossimi alla frontiera con la Russia aggressiva ed in prospettiva instabile, hanno attivato programmi educativi ed esercitazioni di massa per rinforzare il “fronte sociale di difesa”. Così come sta crescendo la capacità di annullare offensive finalizzate al condizionamento delle menti via azioni comunicative subdole. La Russia è maestra, oltre che nella missilistica ad ipervelocità, nelle tecniche comunicative condizionanti. La Cina di più perché è passata dal controllo sociale via quasi due milioni di soldati dell’equivalente ministero degli Interni (tempo fa reclutati in quattro regioni lasciate intenzionalmente povere per stimolarne l’aggressività da invidia contro i nuovi ricchi e giovani istruiti) al controllo dei telefonini e rete con intelligenza artificiale programmata per assegnare un voto di conformità sociale agli individui, poi motivo di compressione o facilitazione delle carriere: tale salto del metodo del controllo è stato fatto per ottenere maggiore efficienza, invisibilità e costi inferiori. Va annotato che questo investimento ha prodotto una futurizzazione competitiva rapida dell’industria cinese nel settore elettronico e cyber che si è trasferita alla capacità militare, e viceversa, dandogli impulso verso la superiorità tecnologica. In sintesi, la spesa per la sicurezza oggi deve includere sistemi di difesa civile e militare coordinati da una politica integrata ed innovativa perché i possibili nemici stanno facendo un salto tecnologico. I nuovi standard Nato recentemente approvati seguono tale modello: in tempi lunghi il 3,5% del Pil per spesa militare e l’1,5% per la sicurezza sistemica non direttamente militare.
Quale spesa militare avrebbe la miglior ricaduta economica, cioè più burro dai cannoni in combinazione con la deterrenza basata sulla superiorità? L’evoluzione della guerra suggerisce: a) robotica aerea, terrestre, marina (Nave Sapiens di Fincantieri è un precursore) e spaziale ad elevata autonomia decisionale; b) controllo dell’orbita qualificata da satelliti distruttori e da strumenti “occhio di Dio” (il trattato di demilitarizzazione dello spazio non è rispettato da alcuno); c) soldati con dotazioni potenzianti, per esempio esoscheletri, e con gemelli robot multifunzionali per ogni reparto; d) ombrelli antimissile multilivello (da pochi chilometri fino all’orbita) e forza aerea correlata di sesta generazione (gestione di sciami di droni) capace di saturazione difensiva, ma anche di azione offensiva qualora la calibratura della deterrenza lo richiedesse; e) sistemi di supermedicina d’emergenza corroborati da robotica chirurgica in prima linea, poi stimolativa di efficientamento delle operazioni ospedaliere civili, e viceversa; d) alimenti superenergetici a basso peso e lunga conservazione sia per missioni militari sia per soccorso in caso di emergenze di massa civili con conseguenze innovative sull’industria del cibo; e) comunicazioni laser non intercettabili; f) sensori biochimici e di contaminazione nucleare; ecc. In sintesi, solo questa lista parziale implica migliaia di nuove tecnologie con ricaduta stimolativa sull’industria civile. Non solo, la domanda di supertecnologie trova un sistema industriale civile pronto ad adattarsi ad un’offerta per i sistemi militari. Non a caso la Banca europea degli investimenti (Bei) ha tolto il divieto per investimenti militari. Se il riarmo prendesse questa via darebbe un megainvestimento sistemico capace di sostenere una reindustrializzazione competitiva dell’Italia. Con chi? Certo non da sola, ma con chiunque sia utile nel mondo Nato, Ue e G7 e compatibile. L’America? Necessaria per alcuni sistemi ancora nel presente e per almeno un decennio, ma va considerato che tecnologia europea ed italiana (britannica e nipponica) hanno capacità di innovazione autonoma. Ovviamente se si restasse su un riarmo orizzontale e non futurizzante la dissipazione finanziaria sarebbe massima. Ma è già visibile nel mondo militare ed industriale la consapevolezza che un salto tecnologico sia necessario, nonché un’accelerazione. Fino all’autonomia nucleare militare? Dipende dall’ingaggio statunitense: ancora da capire.
E la spesa per la sicurezza civile? Avrebbe ricadute di qualificazione territoriale e sociale enormi se indirizzata al potenziamento infrastrutturale, ad una nuova urbanistica che includa la sicurezza evolutiva del territorio, utile, anzi essenziale, per la prevenzione e mitigazione di disastri ambientali, cioè l’ecoadattamento, e a programmi educativi specifici della popolazione. In conclusione, c’è una relazione tra sicurezza e ricchezza che impone investimenti per aumentare la prima, non necessariamente bellicista ed aggressiva, ma realistica.