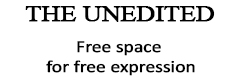Le nazioni dell’Ue mostrano di non voler cedere sovranità oltre una data soglia ad un’Ue confederale. Questo dato di realtà, piaccia o non piaccia, configura l’architettura politica tendenzialmente duratura dell’Eu come “meno di un’unione, ma più di un’alleanza tra nazioni”, per esempio il mercato e la moneta unici europei. Tuttavia, c’è uno spazio di convenienza per tutte le euronazioni ad aumentare la loro collaborazione sul piano dell’alleanza tra nazioni per progetti selettivi seguendo il modello “meno di un’unione, ma stringendo un’alleanza sempre più forte”. Tale spazio non è generato da una volontà europeista idealistica, ma da molteplici necessità di interesse nazionale. Quelle economiche sono chiare anche se per renderle convergenti ci vorrà tempo. Ma va annotata una nuova priorità per l’interesse comune degli europei: la sicurezza non più fornita gratuitamente dagli Stati Uniti. Quindi la novità è che le nazioni europee dovranno spendere più per sicurezza militare e sistemica. Ciò stimola la ricerca di quali programmi militari e di sicurezza dovranno e potranno essere europeizzati e di quali resteranno solo nazionali pur integrabili via standard Nato di interoperabilità.
Con i miei ricercatori, in un progetto di ricerca avviato nello scorso aprile, abbiamo individuato due programmi necessariamente europei/integrati per dare loro efficacia, utilità economica e sociale: a) Eurodome, cioè una cupola di difesa aerea simile allo Iron Dome (cupola di ferro) israeliano, ma con raggio più esteso nello spazio verticale ed orizzontale; b) Cognitive Power (Potere cognitivo) per fornire a governi ed alla popolazione l’informazione necessaria per gestire molteplici problemi di sicurezza.
Eurodome va immaginato in un orizzonte temporale di 15 anni – con realizzazione completa nel 2040 – ma con passi evolutivi. Il primo è l’organizzazione di (euro)comando militare comune, sperabilmente entro il 2027, che generi la collaborazione Nato con la cupola di difesa aerea e spaziale statunitense e definisca i protocolli operativi nonché il fabbisogno tecnologico. Per una parte di questo sistema gli europei sono più evoluti di quanto si pensi – per esempio sul piano degli antimissile a breve distanza - ma per altra parte hanno bisogno di tecnologia statunitense (e israeliana) per poter ottenere una prima versione di Eurodome di almeno minima efficacia entro poco tempo, con enfasi sulla difesa contro missili a ipervelocità ed elevata manovrabilità, tecnologia russa in diffusione. Poi Eurodome dovrebbe conquistare sia più capacità di difesa orizzontale oltre i confini dell’Ue, a copertura dell’intero Mediterraneo e oltre, sia verticale come controllo dell’orbita e dell’ambiente sottomarino. Un calcolo preliminare ipotizza che in dieci anni possano essere generate più di 500 nuove tecnologie poi trasferibili pur degradate all’industria civile (robotica di presidio ed intervento oltre che per le produzioni industriali, sistemi di osservazione, cibernetica evoluta, sistemi spaziali, ingegneria adattiva, ecc.). In sintesi, un controllo del cielo e dello spazio ad elevata sicurezza che diventerebbe un moltiplicatore della fiducia economica e finanziaria e dell’innovazione industriale. Eurodome è il sistema militare da cui si potrà estrarre più “burro dai cannoni” trasformandone la spesa da costo a rischio improduttivo ad investimento produttivo.
Cognitive Power. Anche paneuropeo dovrebbe essere un programma educativo continuo per mettere in grado la popolazione di gestire emergenze: dagli incendi alle alluvioni, dagli attentati terroristici agli attacchi militari, ecc. Tale evoluzione della competenza di massa implica centrali operative che diffondono l’informazione ed i mezzi di gestione. Implica anche la creazione in ogni nazione, con coordinamento europeo, di una riserva di personale specializzato che sul territorio possa guidare organizzazioni locali di contingenza. Sul piano tecnologico ogni cittadino dovrebbe avere uno strumento portatile di comunicazione dove ricevere allerte, indicazioni di cosa fare e dove andare nonché comunicare una situazione di pericolo personale. Bastano i telefonini? No, sarebbe necessaria una nuova tecnologia TCD (Strumenti di connettività totale). I Paesi nordici stanno già sperimentando forme iniziali di sistemi di difesa ad alta partecipazione popolare. Gli studenti? I programmi scolastici dovrebbero essere modificati per l’insegnamento pur basico di capacità di gestione delle emergenze di qualsiasi tipo. Tali insegnamenti dovrebbero includere un incremento forte della competenza generale dei discenti, da saper accendere un fuoco a curare un ferito, da organizzare un rifugio per terremotati ad interagire con un robot dotato di sensori biochimici. Ecc.
E per gli altri sistemi militari? Possono restare nazionali ed integrabili in caso di necessità secondo gli standard Nato. Le quantità? Dipenderanno dalle scelte (geo)politiche nazionali. Per esempio, se l’Italia vuole sostenere il suo export con accordi politici, dovrà mostrare la capacità di fornire sicurezza marittima, sottomarina, spaziale, cyber ed aerea entro diversi formati di alleanza con capacità nazionali forti. Ma contro chi? Io e i miei ricercatori non stiamo pensando solo ai conflitti in atto, ma abbiamo tracciato una linea probabilistica a 15 anni dove vi sarà il problema di sostituzione, per motivi naturali o altro, dei leader dei regimi autoritari. In questi la sostituzione delle élite non è regolata da elezioni, ma da conflitto tra cordate: potranno emergere leader pacifici come estremi. In conclusione, c’è una varietà di regimi instabili nel mondo che non permette di rendere realistica una pur sperata pace globale duratura e condivisa. Quindi la sicurezza resta una priorità così come il suo collegamento alla produttività economica.