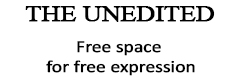La Germania sottoposta a pressioni sia geopolitiche sia geoeconomiche, nonché in recessione da mesi, si è risvegliata preparando un nuovo progetto nazionale e modificando il limite costituzionale al debito. Valutiamo tale mossa in relazione all’interesse dell’Italia.
Pochi giorni prima della scadenza del vecchio parlamento tedesco, il leader dei democristiani (Cdu-Csu) tedeschi Frederich Merc è riuscito a convincere quello socialdemocratico (Spd) ed i Verdi ad approvare una modifica costituzionale prima dell’insediamento del nuovo parlamento dove la probabile coalizione tra democristiani e socialdemocratici (Verdi all’opposizione e Liberali fuori dal parlamento) avrà una buona maggioranza, ma non sufficiente per variazioni costituzionali. Già solo questo atto mostra una capacità di coesione nazionale della politica tedesca non rilevabile in altre democrazie. Uno potrebbe dire che i Verdi hanno richiesto un prezzo molto alto per la loro convergenza: circa 100 miliardi sui 500 del programma di modernizzazione infrastrutturale – a debito – dovranno essere destinati ad opere compatibili con la transizione ecologica. Ma pesa di più il consenso ad un progetto sia di rilancio dell’economia nazionale sia di riarmo che, di fatto, non avrà limiti. Alcuni economisti stimano che il debito tedesco passerà dall’attuale cifra poco sopra il 60% del Pil allo 80-90%. Berlino non avrà problemi a sostenerlo, trovando compratori dei titoli, in comparazione con altre grandi economie il cui debito viaggia oltre il 100% del Pil. Berlino può infatti contare su una stabilità e convergenza della politica interna superiore agli altri (caratteristica che influenza molto il punteggio di rischio e costo del debito).
C’è qualche dato sul nuovo progetto nazionale tedesco che permetta uno scenario? Qualche spiffero dai think tank con cui il mio ha un dialogo frequente, ma niente di strutturato: è in fase di negoziato riservato tra democristiani e socialdemocratici. La sensazione preliminare, tuttavia, è che i due partiti vogliano andare veloci. Questa è correlata con la percezione che il pensiero tedesco percepisca un’emergenza a cui rispondere con la ricostruzione della potenza nazionale. Non quella implicita perseguita da Helmut Kohl (va bene l’euro imposto dalla Francia, ma dovrà essere come il marco), dal furbo Gerhard Schroeder (affidare alla Francia il no all’intervento statunitense in Iraq e allo stesso tempo fornire la principale base logistica all’America) e dalla furbissima – con dottorato di ricerca in Chimica-Fisica – Angela Merkel (far finta di convergere con l’America mentre la vera strategia era euroasiatica, come quella di Schroeder per altro, e di dominio incontrastato, pur travestito, dell’Ue). Olaf Scholz non è riuscito a fare come i suoi predecessori perché l’America ha compresso la Germania ed egli non ha trovato la forza e la strategia per evitarlo in combinazione con l’impossibilità di avere relazioni con la Russia e con la trasformazione della Cina da partner a concorrente dell’industria tedesca. Merc non è particolarmente amato dall’elettorato e da una parte del suo partito, ma questa necessaria capacità strategica sembra averla, anche derivata dal ruolo di rappresentante in Germania di uno dei più grandi fondi di investimento del mondo (americano) per anni. Infatti ha pensato subito ai soldi necessari per un progetto nazionale di potenza prima di esplicitarne i dettagli.
Tuttavia, qualcosa si può intuire. Il riarmo sarà uno strumento di rilancio dell’industria tecnologica tedesca. Alcuni analisti sostengono che servirà a compensare la riduzione dell’industria automobilistica. In parte è certamente vero, ma è probabile la ricerca di una superiorità tecnologica molto più vasta. Uno spiffero ha segnalato che abbia insistito con Ursula von der Leyen per denominare il programma militare europeo come “Riarmare l’Europa” e non come “Difendere l’Europa”. Un altro ha svelato una tale posizione da parte di Parigi. Difficile saperlo, ma il dato è che Francia e Germania sono per un riarmo massivo. E un altro dato è che Londra converga. Altri dati segnalano che gli europei, con eccezione di Italia, Polonia e pochi altri, vogliano mostrare all’America a conduzione Donald Trump una capacità di contrasto superiore alla necessità di farlo. Per Londra, pur nell’interesse di non rompere la convergenza con l’America, è necessario per la sua missione di tutela del Canada e delle nazioni baltiche, tra cui la Danimarca pressata per cedere la Groenlandia. Per Francia e Germania c’è l’opportunità percepita di stabilire una relazione Ue – Usa tra forti, francamente un po’ illusoria. Ma non è illusorio il risveglio del pensiero strategico tedesco per cercare la via di una nuova politica di potenza, per intanto – novità - ben finanziata, trattando gli europei come oggetti da allineare.
Per l’Italia sarebbe necessario valutare quanto il risveglio tedesco sia positivo o negativo per i suoi interessi. Potrebbe essere molto positivo per il rimbalzo di un’economia che assorbe più del 10% del nostro export. Anche positivo per collaborazioni nel settore dell’alta tecnologia dove in alcuni settori l’Italia è più avanzata. C’è anche l’interesse comune a mantenere i livelli di export sul mercato statunitense ed altrove. Ma c’è anche un rischio di concorrenza eccessiva nei mercati africani, arabi e del Pacifico e nella stessa Ue, nonché di accordi geoeconomici sfavorevoli all’Italia, ecc. Uno potrebbe dire che il bilaterale Germania – Italia è ottimo. Ma non è vero dopo che Roma ha firmato con Parigi il “Trattato del Quirinale” senza cercarne uno equivalente con la Germania mentre Berlino cercava di depotenziare la diarchia franco-tedesca. In sintesi, c’è un problema di fiducia tra Roma e Berlino. Che va risolto inaugurando consultazioni bilaterali periodiche e frequenti.