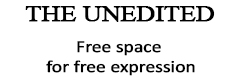L’Amministrazione Obama, nel 2013, concepì la creazione di due aree di libero scambio, una nel Pacifico (Tpp, 12 nazioni + circa 16 potenziali) e una nell’Atlantico (Ttip, bilaterale con l’Ue), ambedue con al centro il mercato statunitense, ma tenendole separate. L’intento, oltre a quelli di ridurre il deficit commerciale statunitense attraverso trattati di scambio simmetrico ed escludere Cina e Russia, con la priorità di condizionare la prima, era quello di impedire accordi economici diretti tra europei ed asiatici per dominarli meglio. Nel 2017 l’Amministrazione Trump ritirò l’America dal trattato asiatico e congelò quello euroamericano. Per Giappone, Australia, Canada, ecc. fu un trauma che li spinse a cercare accordi con l’Ue. Bruxelles colse l’occasione e li facilitò. Il trattato Ceta tra Ue e Canada è già attivo e in via di conferma finale. Nel marzo 2019 sarà attivato quello, similare, con il Giappone. Altri sono in trattativa, pur più lenta per difficoltà nel settore agricolo, con Australia, Mercosur, ecc. Il punto: la strategia di Trump ha paradossalmente favorito una relazione diretta tra Ue, Asia democratica, Sudamerica, e pezzi del Nordamerica quali Canada e Messico, che indeboliscono la capacità dissuasiva statunitense. La Casa bianca se ne è accorta e in ottobre, oltre ad accelerare l’accordo post-Nafta, ha inviato al Congresso un piano per aprire trattati commerciali simmetrici con Ue, Regno Unito e Giappone. Scenario: per non finire isolata, considerando che l’integrazione commerciale implica convergenze geopolitiche e monetarie, l’America dovrà fare come l’Ue. Ciò fa ipotizzare una matrice di accordi bilaterali di tutti con tutti che darebbe vita ad un mercato globale delle democrazie, equivalente a circa il 70% del Pil mondiale, a istituzionalizzazione progressiva: creazione di un prestatore areale di ultima istanza, ampliamento del G7, ecc. Ma gli esclusi saboteranno, l’America non vuole un nuovo multilateralismo, l’Ue è frenata dal protezionismo francese. Che il nuovo mercato si realizzi è interesse vitale dell’Italia perché la sua piccola industria godrebbe di minori costi per l’export ed il suo debito sarebbe garantito indirettamente dal nuovo prestatore areale, bilanciando la difficoltà della Bce a farlo. La Germania non ha il secondo problema, ma sarebbe superfavorita dal primo vantaggio. Pertanto sembra possibile un’alleanza italo-tedesca che porti l’Ue in convergenza euroamericana così consolidando il nuovo reticolo globale e risolvendo i suoi problemi interni via stabilizzazione esterna